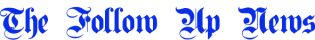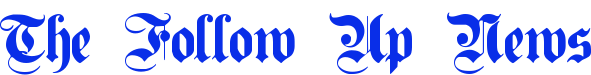Tradurre la prosa di Dylan? Un incubo
Filosofia della canzone moderna di Feltrinelli
Intervista ad Alessandro Carrera che ha curato la traduzione, garanzia assoluta per un risultato scrupoloso vuoi per la preparazione del professore con cattedra universitaria a Houston vuoi per la sua conoscenza completa della res dylaniana.
Alla voce del professor Carrera, lumi e dubbi su questa nuova opera…
Gli appassionati di Dylan lo aspettavano da almeno un anno e finalmente adesso lo hanno per le mani. Filosofia della canzone moderna (Feltrinelli, pagg. 352, euro 39) è un viaggio lungo sessantasei canzoni raccontato da Bob Dylan. Un’edizione scintillante (e dal prezzo ovviamente alto) che si avvale di un vero e proprio album di foto che aiuta a viaggiare col narratore.
Come sempre, la traduzione di Dylan è stata affidata ad Alessandro Carrera, garanzia assoluta per un risultato scrupoloso vuoi per la preparazione del professore con cattedra universitaria a Houston vuoi per la sua conoscenza completa della res dylaniana.
Alla voce del professor Carrera, lumi e dubbi su questa nuova opera.
Com’è stato affrontare questo nuovo capitolo della scrittura di Bob Dylan?
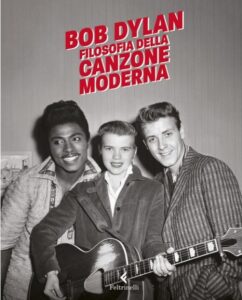
La scrittura di Bob Dylan è sempre un incubo, e parlo della prosa perché le canzoni, nonostante i loro giochi di parole e la molteplicità di significati, sono molto più facili da tradurre. Dylan usa la scrittura, ma non è uno scrittore. Se scrive versi, li modella sulla musica e soprattutto su come la sua voce li può pronunciare. Anche in prosa, scrive sempre come se stesse cantando o recitando. A volte ne risulta una prosa poetica, a volte caotica, piuttosto goffa o comunque molto disuguale. Non sai mai cosa ti aspetta alla prossima frase. Può venir fuori con giri di parole originalissimi oppure con una cosa buttata lì che non sembra riletta neanche una volta. Però Dylan è unico anche in questo, prendere o lasciare, perché il mondo è pieno di gente che scrive benissimo o malissimo, ma nessuno saprebbe mai scrivere una frase di Dylan, neanche la più abborracciata.
C’è un fil rouge tra la scrittura di Chronicles e quella che ha incontrato in quest’ultimo capitolo?
Non molto, a dire il vero. Se escludiamo le raccolte di Lyrics e le poesie degli anni Sessanta, che spero prima o poi vedranno la luce in un’edizione complessiva, Dylan ha scritto tre libri: Tarantula (1971, ma scritto soprattutto nel 1965), Chronicles Vol. 1 (2004) e Filosofia della canzone moderna (2022). Aggiungo The Nobel Lecture (2017), che in vari modi, anche stilistici, fa da ponte tra le cronache e la filosofia della canzone.
Sono scritti dalla stessa persona, ma non hanno molto in comune. Tarantula è un prosimetro, un misto di versi e prosa che rientra, molto a suo modo, nella letteratura sperimentale degli anni Sessanta. È influenzato dalla scrittura Beat, ma può anche essere letto come una strana parodia del Beat. È il libro di un nipotino di Joyce che non ha mai letto Joyce ma ha sfogliato qualcosa di Burroughs. Chronicles invece è un libro serio o almeno si presenta come tale. Non è un’autobiografia. È una serie di schizzi che Dylan ha tratto dalla sua vita, inventando e falsificando anche molto (non ne ho la certezza ma è molto probabile), ma comunque costruendo una narrazione che funziona e che ha una forte coerenza interna. Filosofia della canzone moderna è un tentativo diverso di unire prosa e poesia. La poesia è lasciata alle improvvisazioni verbali che amplificano il testo della canzone presa in esame. La prosa è costituita dalle parti analitiche, alle quali si aggiungono informazioni storiche o digressioni su qualunque cosa gli salti in mente. Non è caotico come Tarantula, ma non è coerente come Chronicles.
Che giudizio dà all’opera complessiva?
Questo forse non lo si dovrebbe chiedere al traduttore, che sviluppa un rapporto troppo stretto con l’opera di partenza e alla fine ha in mente solo l’opera di arrivo, le parole che ha trovato per rendere il testo in un’altra lingua. Alla prima lettura la mia impressione era stata piuttosto negativa. L’altalena stilistica tra un capitolo e l’altro mi aveva un po’ scoraggiato. Addentrandomi nel lavoro di traduzione ho cambiato il mio giudizio, in particolare quando mi sono reso conto che quel testo non era affatto “scritto”. Filosofia della canzone moderna è un libro orale.
Cosa intende quando afferma che un certo testo non è stato scritto?
Che arrivo a ipotizzare che molte pagine non sono neanche state scritte, sono state dettate e nemmeno editate, se non in minima

parte. Buona la prima, insomma. Me lo fanno capire la brevità delle frasi, le costanti ripetizioni che enfatizzano ciò che è stato appena detto, le numerose endiadi che vengono naturali quando parli ma appaiono subito inutili quando scrivi. Cito un esempio, dal commento a Take Me from the Garden of Evil: “Hai fede, sei intrepido e imperterrito, imperturbabile e stufo di essere incaprettato e impedito”. Non bastava dire: “Sei intrepido, imperturbabile e stufo di essere impedito”? Insomma, ancora una volta ho dovuto tradurre una voce ed è stato un problema, perché una traduzione assolutamente letterale sarebbe risultata in un brutto italiano, avrei fatto la figura del traduttore che “scrive male”. E d’altra parte non potevo alterare l’originale. Ho raggiunto un compromesso collegando molte frasi brevi tra di loro ed eliminando varie ripetizioni che in italiano (lingua molto sensibile alle ripetizioni, più dell’inglese) avrebbero veramente disturbato.
Quindi la sua musicalità sta una volta di più nella sua voce più che nella sua parola, mi par di capire?
Filosofia della canzone moderna è un libro da ascoltare, bisognerebbe leggerlo in italiano ascoltando la voce di Dylan che lo recita in inglese. Di fatto, si tratta di una continuazione con altri mezzi della trasmissione radiofonica che Dylan ha condotto nel 2009 e nel 2010. So che è uscito o sta per uscire un audiobook in cui Dylan legge le parti “poetiche” mentre una schiera di attori piuttosto famosi legge le altre. Avrei preferito che Dylan lo leggesse interamente, ma ci accontenteremo. Ho sentito un’anticipazione, e precisamente il capitolo su Strangers in the Night. Ecco, già solo sentire la maniera cadenzata e percussiva con la quale Dylan pronuncia “Strangers in the Night” fa capire che Filosofia della canzone moderna è fondamentalmente un libro-podcast. Quando Dylan produce qualcosa di nuovo, ci si deve chiedere solo se vi sentiamo la sua voce. E qui la voce è presente in tutta la sua gloria, bellezza e sciatteria.
Quale, tra le 66 storie, l’ha colpita di più?
Quella di John Trudell, il poeta-attivista nativo americano morto nel 2015 e che ha avuto una vita davvero tragica. Buona parte delle informazioni che Dylan fornisce si possono trovare anche su Wikipedia, ma Dylan introduce un particolare che su Wikipedia non c’è. Vale a dire, la roulotte dove la suocera, la moglie e le figlie di John Trudell sono state bruciate vive, in un incendio doloso causato da ignoti, era stata chiusa dall’esterno con un lucchetto. Senza questo particolare non si capisce come la famiglia di Trudell non sia riuscita a salvarsi. In questo capitolo Dylan non si lascia andare ad amplificazioni ridondanti. La sua partecipazione alla poesia-canzone di Trudell, Doesn’t Hurt Anymore (2001) è totale.
Dylan più di una volta ha dato modo di avere a cuore le radici di Trudell.
Dylan viene dal Minnesota, conosce la realtà dei nativi americani e ha sostenuto in passato che il peccato originale dell’America non è solo la schiavitù ma anche quello che è stato fatto ai nativi, il continuo inganno, sulla base di promesse non mantenute e trattati non rispettati, compiuto dai conquistatori nei loro confronti. Le pagine che Dylan dedica a John Trudell mi sono sembrate le più commosse e sincere dell’intero libro. Considerando l’idea generale di “giustizia” in Dylan, è interessante anche la distinzione che pone tra criminale e fuorilegge, nel capitolo dedicato a Jesse James. Proprio in questi giorni ho ricevuto un bel libro di Tommaso Gazzolo, che insegna filosofia del diritto a Sassari. Si intitola La vita fuorilegge. Storia filosofica del Far West (Salerno Editrice 2022) e contiene svariati riferimenti a Dylan. Nascono dal famoso verso di Absolutely Sweet Marie, “per vivere al di fuori della legge, devi essere onesto” (to live outside the law, you must be honest), che Dylan prende dal film Crimine silenzioso di Don Siegel. In un certo senso, il capitolo su Jesse James completa il libro di Gazzolo. Il criminale si serve della legge, il fuorilegge non può. Nessuno lo protegge. La sua unica possibilità di sopravvivere sta nella sua onestà verso i suoi pari e nell’onestà dei suoi pari verso di lui, che non è affatto garantita, come dimostra la storia di Jesse James tradito dal suo migliore amico.
Se lo aspettava un capitolo dedicato a Volare?

No, non me l’aspettavo, ma l’affermazione di Dylan, cioè che Volare è una canzone allucinogena, psichedelica, ben prima di White Rabbit dei Jefferson Airplane, è geniale. Perché Nel blu dipinto di blu è davvero il simbolo di quella allucinazione di massa che è stato il boom economico italiano. Un’allucinazione dalla quale l’Italia si è svegliata dapprima nel 1964 con una crisi di sovrapproduzione che allora è stata definita “la congiuntura” e poi con le lotte sindacali del 1969, quando la classe operaia comprese che la realtà del lavoro e dei salari non poteva più essere compensata dall’allucinazione che tutto stesse andando come meglio non si poteva. Dylan ovviamente non fa un’analisi sociale, a lui Volare interessa precisamente in quanto canzone psichedelica ante litteram, cosa che gli permette di scatenare uno dei suoi poemi più enfatici, al limite dell’assurdo. Ma lo spunto iniziale giustifica tutto.
Dylan pesca soprattutto nel repertorio del ventennio ’50-’60. Un titolo degli anni Novanta e due del nuovo millennio. Un idem sentire con Francesco Guccini che ha affermato di non ascoltare canzoni delle ultime decadi perché le ritiene inutili?
Il titolo del libro è stato spesso frainteso. “Canzone moderna” non significa canzone contemporanea. Significa canzone “modernista”, che cioè fa parte di quel grande movimento estetico e culturale che ha creato l’arte e la sensibilità del ventesimo secolo dal 1910 fino ai primi anni Ottanta. Dal futurismo al punk, insomma. Il punk che, per riprendere la tesi di Greil Marcus nel suo Tracce di rossetto (Odoya 2010), è stata appunto l’ultima avanguardia del Novecento. Pensiamo a quell’automobile anni Quaranta che sfreccia in sovraesposizione sulla copertina di Modern Times. I “tempi moderni” sono gli anni di Chaplin e di Joyce, di Picasso e di Hollywood, del design sinuoso e dell’architettura di Frank Lloyd Wright, e soprattutto del blues, del jazz e dello swing.
Questa è la “canzone moderna”, che poi si ramifica nel rhythm and blues, nel rock ‘n’ roll, nel rock-pop nelle sue varie forme fino appunto al punk. Quello che è successo dopo lo potremmo definire canzone postmoderna, e richiederebbe un’altra trattazione. È anche il motivo, credo, per cui nel libro non si parla di hip-hop, che insieme al minimalismo è forse la principale forma d’arte musicale postmoderna, e certamente è una cosa diversa dalla “canzone”.
Non credo che Dylan ignori ciò che accade nella popular music di oggi, tant’è vero che ha reclutato Fiona Apple per una particina in Rough and Rowdy Ways, ma non credo che si ritenga la persona adatta per giudicare la musica attuale. La canzone più recente di cui tratta è Dirty Life and Times di Warren Zevon, incisa nel 2003, Ma Zevon è appunto un autore di “canzoni moderne”, non postmoderne.
Una carrellata americano-centrica con qualche concessione extra. Che anima dylaniana viene fuori da una scelta come questa?
Dylan ascolta anche musica non anglosassone, ad esempio del Medio Oriente, ma non credo proprio che si ritenga un esperto di world music. Il suo campo è la canzone anglo-americana in tutte le sue forme. Questo rende ancora più sorprendente la scelta di Volare, perché è l’unica canzone straniera discussa nella sua versione originale. Dylan include La Mer di Charles Trenet, di Mackie Messer di Brecht e Weill e anche My Prayer, che è una melodia francese di Georges Boulanger, ma a parte Volare tratta solo le cover americane. L’anima che esce da questo libro è fondamentalmente quella di Dylan adolescente. Buona parte delle canzoni di cui parla risalgono alla metà degli anni Cinquanta. Sono quelle che poteva ascoltare accendendo la radio a Hibbing, tenendola accesa a notte fonda per captare le stazioni di blues e rhythm and blues che lanciavano le loro onde sonore dal Messico, dal Texas e dalla Louisiana. Ma c’è anche del normalissimo pop, che poteva ascoltare alla radio di giorno.
Stupisce la carenza femminile. Quattro voci, di cui due di attrici, e un pugno di autrici. Un po’ poco considerata la vasta conoscenza della materia dell’autore, non trova?
Oh, questo è il capitolo doloroso, e che ha attirato al libro le maggiori critiche, peraltro più che giustificate. Ma vediamo di fare chiarezza. Le voci sono Cher, Rosemary Clooney, Judy Garland e Nina Simone. Le autrici sono Mary Jean Shurtz (co-autrice di There Stands the Glass), Dorothy LaBostrie (co-autrice di Tutti Frutti), Sharon Sheeley (autrice di Poor Little Fool), Cindy Walker (co-autrice di You Don’t Know Me), Mrs. Elmer Laird (autrice di Poison Love), Cousin Emmy (autrice di Ruby, Are You Mad?) e Cynthia Weil (co-autrice di Saturday Night at the Movie).
Dylan dedica poi alcune pagine a Leigh Brackett, autrice di gialli, fantascienza e co-sceneggiatrice di L’impero colpisce ancora (in relazione a Black Magic Woman) e a Marie Laveau, leggendaria sacerdotessa vudù di New Orleans (in relazione a Witchy Woman). Lascio al lettore il piacere o la perplessità di scoprire il rapporto tra queste due donne, entrambe a loro modo detentrici di qualche magia, e le canzoni alle quali sono state accostate. Certamente Dylan avrebbe potuto rispettare le quote e inserire 33 canzoni interamente scritte o cantate da donne (sul New Yorker del 15 novembre è uscita una interessante playlist alternativa di 66 women songs, proposta da Amanda Petrusich, che davvero potrebbe essere l’inizio di un appassionante confronto). Non l’ha fatto, ma non è questo che mi preoccupa. Sono rimasto piuttosto sconcertato, invece, dal linguaggio veramente misogino di alcuni passaggi.
Per carità, Dylan è nato nel 1941. Non credo che nessun rappresentante del sesso maschile nato in quegli anni possa scuotersi di dosso una certa misoginia congenita. Il mondo del rock poi era maschilista fino alla follia, e rispetto ad altri personaggi, famosi quanto lui, Dylan fa quasi la figura del morigerato. I suoi tratti misogini peraltro sono sempre stati bene in vista, a partire da Don’t Think Twice It’s Alright, It Ain’t Me, Babe e Just Like a Woman. Ma erano canzoni di cui una donna si poteva appropriare, e che cantate da Joan Baez, Judy Collins, Nina Simone e altre prendono un aspetto completamente diverso (It Ain’t Me, Babe è stata anche usata come canzone femminista). Non c’è possibile riscatto, invece, per quelle righe veramente crude di Filosofia della canzone moderna. È vero, sono poche, ed estrapolate dal contesto sembrano peggio di quello che sono. C’è una descrizione della femminista anni Settanta come “donna strega”, ma molte donne a quell’epoca avrebbero rivendicato il termine (vi ricordate lo slogan, “Tremate, tremate, le streghe son tornate?”). E descrivere la donna strega come “sovvertitrice di culture, tradizioni, identità e divinità” non è un insulto, è un complimento. Il paragrafo poi è legato al ritratto di Marie Laveau come astuta donna d’affari, che segue subito dopo. Ciò non toglie però che il linguaggio sia a volte inaccettabile. Ero imbarazzato per lui mentre lo traducevo. Ma chi gliel’ha fatto fare, pensavo. Poteva dire le stesse cose, se proprio voleva, con un linguaggio meno violento, che oltretutto non gli è mai appartenuto.
È vero però che negli ultimi dischi Dylan va giù pesante (penso a Black Rider, ma non solo). Forse ha letto troppa poesia satirica latina, che non è nota per il savoir faire, e nella sua voracità linguistica ha voluto appropriarsi anche del lessico volgare. Il vero imbarazzo nasce però quando Dylan non si rende conto di sparare delle vere idiozie. Come quando in nome della sua filosofia libertaria propone la poligamia, tanto per gli uomini quanto per le donne, aggiungendo che per una donna martoriata dalla vita e che vive in mezzo a una strada sarebbe molto meglio diventare una delle mogli di un ricco piuttosto che vivere di buoni pasto federali. A parte l’insulto alla dignità della persona, se incontrassi Dylan gli vorrei chiedere: ma tu pensi davvero che un ricco vada a cercare le sue mogli tra le senzatetto che vivono sotto i piloni delle sopraelevate di Los Angeles?
Premesso che si tratta di saggio e non di una Treccani della canzone, non al traduttore ma al conoscitore della popular song chiedo: c’è un’assenza che si fa sentire?
Ce ne sono moltissime, ma non credo che abbia molto senso farne una lista. Non c’è Woody Guthrie ma c’è Pete Seeger, non c’è Robert Johnson ma c’è Jimmy Reed, non c’è Joni Mitchell ma c’è Nina Simone, non ci sono i Beatles ma ci sono gli Who, e si potrebbe continuare, ma questo è il libro di un disc jockey, la settimana di un affabulatore notturno che mette su una quindicina di pezzi, ci fa sopra un bel rap dissennato come può venire fuori soltanto alle tre di notte dopo aver bevuto qualcosa di forte e fumato qualcosa di più forte ancora e se ne va a casa barcollando alle prime luci dell’alba. Un dj che ha deciso di non darsi nessun tema se non quello dell’impulso del momento.
Possibile ipotizzare un collegamento tra le canzoni analizzate?
Non c’è un filo che lega queste 66 canzoni, e sembra proprio che Dylan non voglia che ci sia. Avrebbero potuto essere tutte

diverse. Avrebbero potuto essere di più o di meno, ma non credo che né la scelta né il numero nascondano chissà quale messaggio. Sono schede mentali, estratte dal cervello di qualcuno sinceramente convinto che la canzone, e in particolare la “canzone moderna”, sia una grandissima forma d’arte, e che anche il più scontato dei ritornelli, se possiede quel certo non so che di indefinibile che ti si attacca addosso e non si fa dimenticare, ti possa cambiare la vita. Chiunque può scrivere qualcosa su Yesterday, ma se Dylan mi dice che Feel So Good di Sonny Burgess, incisa dalla Sun Records nel 1957 e rimasta inedita per decenni, è il sound che ha fatto grande l’America, e che per questa ragione è un disco politico, di sicuro mi risveglia l’attenzione. E se mi dice che El Paso di Marty Robbins sembra una storia western di amori selvaggi e di furti di cavalli ma in realtà è una canzone sull’olocausto nucleare, o se mi dice che le scarpe di camoscio blu, le Blue Suede Shoes di Carl Perkins simbolizzano la chiesa e lo stato, penso due cose: la prima è che Dylan è pazzo, e la seconda è che c’è qualche angolo della psiche cosmica in cui ha assolutamente ragione.
Tra le tante immagini che corredano il libro, che effetto le hanno fatto le ricorrenti foto di vecchi negozi di dischi con vetrine ed espositori pieni di LP e frequentati da tanti giovani?
Certo, è un lamento funebre sulla cultura del disco. Quando ho vissuto a New York, dal 1995 al 2001, quei negozi che si vedono nelle fotografie incluse nel libro esistevano ancora. Erano botteghe di dischi nuovi e usati, LP e CD, grandi, cavernosi, su Bleecker Street, Thompson Street, sulla 8th Street e un po’ dovunque nel Village. Me ne ricordo uno in particolare sulla 17th Street West, sempre affollatissimo. Mi ricordo di Tower Records su Union Square e del Tower Records di fianco al Met, immenso, un vero luogo di perdizione. Nel 2003, con la comparsa di Napster e del Mp3, quel mondo è sparito con rapidità catastrofica. Il negozio di dischi era uno spazio interiore, un viaggio che compivi dentro te stesso o in compagnia di pochi amici molto ma molto fidati. Perdevi il contatto con l’esterno, eri nell’iperspazio. C’è quasi una vendetta della storia, adesso, nel fatto che i CD sono quasi scomparsi dai negozi e che invece siano ritornati i dischi in vinile come prodotti di lusso, ben impacchettati e costosi, più come riproduzioni d’arte che come oggetti d’uso.
Fa specie vedere un libro tradotto da lei senza il corposo corredo di note che per i dylaniani sono preziose quanto il testo.
Le varie pagine di note che ho scritto dovevano entrare nel libro, così come le note scritte per Tarantula, Chronicles Vol. 1 e i tomi
delle Lyrics. Non sembrava che ci fossero problemi, ma Feltrinelli doveva chiedere l’autorizzazione e a quel punto credo che sia successa una serie di fraintendimenti. Non per colpa della Feltrinelli, ci tenevano molto alle note. Qualcuno all’agenzia letteraria di Dylan o alla casa editrice americana non ha capito, o ha chiamato l’ufficio di Dylan e non si è fatto capire. Credo che la persona sbagliata abbia parlato alla persona sbagliata.
Per farla breve, la risposta è stata che il libro doveva corrispondere pagina per pagina all’edizione americana e quindi ulteriori pagine non potevano essere aggiunte. Così le note sono finite sul sito Feltrinelli e il lettore può trovare il rimando nella pagina del copyright. Forse qualcuno le andrà a leggere, la maggior parte non se ne accorgerà nemmeno. Mi spiace molto, perché alcune canzoni che in America hanno una storia in Italia non ne hanno nessuna. Un caso esemplare è quello di Whiffenpoof Song, una canzone goliardica composta nel 1907 da alcuni studenti dell’università di Yale e che nasce come parodia di una celebre poesia di Rudyard Kipling. Se non si conosce la poesia di Kipling non si può nemmeno capire l’uso che ne fa Dylan. La descrizione di quella canzone come se fosse uno scrigno di segreti arcani è insieme seria e ironica. Sapendo quali sono i sottintesi, chi la va a sentire capisce lo scherzo. Ma i sottintesi bisogna conoscerli, altrimenti sembra davvero che Dylan stia delirando. Che posso dire? Andate a leggervi le note: https://www.feltrinellieditore.it/filosofia-della-canzone-moderna-note-del-traduttore/
Extra libro: ha avuto occasione di ascoltare dal vivo Dylan nel tour che sta portando in giro in tutto il mondo. Come sta il Nostro?
L’ho sentito l’11 marzo del 2022 a Sugar Land, vicino a Houston, prima che cominciasse a sequestrare i telefonini all’ingresso per impedire le registrazioni pirata. Lo dico perché quello è stato l’unico caso in cui ho registrato un suo concerto. Non l’avevo mai fatto e ormai non ne avrò più occasione. Ho saputo poi che i collezionisti che chattano su www.expectingrain.com cercavano invano proprio la registrazione di quella sera e gliel’ho fatta avere. Dylan certamente era in forma, anche se prima di adeguare la voce alla canzone che stava cantando, nonché al gruppo, gli ci è voluto più tempo del solito. Durante la prima mezz’ora sono rimasto ad ascoltare; dopo ho cominciato ad apprezzare. È curioso, ma la canzone che più mi è rimasta in mente è stata To Be Alone with You. Una canzonetta poco impegnativa, ma Dylan deve aver pronunciato qualche formula magica che conosce solo lui, e ha tratto un effetto trascendente anche da un brano minore. Long may you run, come direbbe il suo amico Neil Young. Che la tua strada sia lunga.
Corrado Ori Tanzi