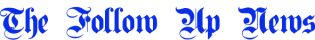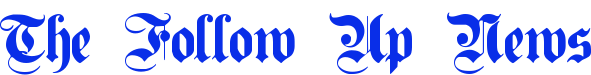Quel candelotto di dinamite chiamato “Skip” Spence
Dal 18 aprile 1946 al 16 aprile 1999. Da Windsor (Canada) a Santa Cruz, terra californiana. Nel mezzo, la sfregiata storia del più devastato musicista del rock
Per parlare di questo artista, padre di un culto i cui adepti preferiscono non venga troppo divulgato, ecco Massimo Padalino, scrittore, critico musicale, saggista…
Alexander Lee “Skip” Spence è la gemma più oscura che la musica contemporanea abbia buttato nel cosmo. Da un lato le sue composizioni che, a distanza di decenni, ancora ci spingono all’interno di una caverna dentro cui una luce fiabesca ci conduce nelle ferite e nella pazzia dell’animo umano, dall’altro una parabola esistenziale dettata da scossoni mentali improvvisi che la hanno fatta rotolare ai margini del margine della convivenza sociale.
Per parlare di questo artista, padre di un culto i cui adepti preferiscono non venga troppo divulgato, ecco Massimo Padalino, scrittore, critico musicale, saggista.
Quando e come s’imbatté in “Skip” Spence?
Comprai a inizio anni Novanta una ristampa di Oar in Lp dei tardi anni Ottanta, edita dalla Edsel; poi verso il 1999 o giù di lì riacquistai la ristampa in cd della benemerita Sundazed, etichetta discografica dedita a ripescaggi Sixties e non solo davvero lungimirante.
All’inizio, lo ascoltai sulla scia della sua leggenda; Oar arrivava alle orecchie degli ascoltatori più attenti e smaliziati con tutto il peso di un mito minore. Infatti, Alexander “Skip” Spence è parte integrante della storia gloriosa della psichedelia californiana.
Da subito le cose non gli andarono proprio bene.

Già a tempi dei Jefferson non è che fosse un tipo esattamente affidabile, e in effetti fu proprio a causa della sua scarsa affidabilità che fu congedato dalla band, mentre coi Moby Grape esploderà l’uomo Spence: schizofrenia conclamata condita da paranoia.
Questo il verdetto, che marchiò a fuoco la vita di un uomo che un giorno, all’inizio del 1999, verrà ricoverato al Dominican Hospital di Santa Cruz per sospetta polmonite e undici giorni dopo ne uscirà cadavere. Causa del decesso: cancro ai polmoni, fase finale.
Può essere inserito nella stessa maledetta famiglia di Syd Barrett, Bill Fay, Nick Drake & Co. o fu vittima e carnefice di una maledizione tutta sua?
No, direi che non può essere inserito in questo tipo di “album di famiglia” di picchiatelli/schizzatelli del rock, e non può esserlo per un semplice motivo: Spence era tutt’altro che un depresso cronico à la Drake, e non era nemmeno uno che si perdeva nei meandri delle proprie cosmogonie psichiche come Syd Barrett.
Con Bill Fay ha poco o nulla a che fare a livello caratteriale e, come un po’ tutti questi, anche se per almeno uno di loro la vulgata continua a descriverlo così, non fu bruciato dall’LSD.
Che tipo di maledetto fu allora?
Fu un ipercreativo, questo è certo; ma fu anche un tipo da “una botta e via”, parliamo del meraviglioso disco, Oar, uscito nel 1969, mentre per quanto riguarda la vita privata, e qui sta tutta la differenza coi nomi che ha citato, Spence fu un tipo sempre in movimento, iperattivo, sempre pronto a fare cose, vedere gente, visitare posti.
Più vittima o più carnefice di se stesso?
Il carnefice è qualcuno che impartisce una punizione fisica dolorosa con sapienza affinché il malcapitato di turno sappia che sta per “godere” di un tour nel dolore sapientemente dosato, rallentato, sceneggiato persino.
Spence fu più un candelotto di dinamite che esplode nelle mani di un bambino. Spence aveva dei tratti del carattere autenticamente fanciulleschi, e anche un po’ minchioni.
Accetta o rifiuta per lui il termine outsider?
Più outsider di lui non c’è nessuno, se non sono outsider i tizi da lei prima citati, o il cantante nonché chitarrista dei 13th Floor Elevators, Roky Erickson, allora non so chi possa essere definito outsider, intendendo con questo termine colui che guarda il sistema da fuori a dentro pertanto in opposizione all’insider, che invece guarda il Sistema da dentro a fuori.
Lo presero con un’ascia in mano in cerca di scannare qualcuno in una camera e poi in sala d’incisione. Risultato: sei mesi al Bellevue Hospital di New York, famoso per il reparto psichiatrico. Che cosa era scattato?
Giugno 1968. I Mody Grape volano a New York per registrare il loro secondo album Wow/Grape Jam. L’incidente fatale, in cui la

pazzia del canadese dilagò, avviene una sera, dopo un concerto al Fillmore East. Acido.
Compagnie sbagliate. Una stanza d’albergo. Ventidue anni appena, e Alexander non si sa perché sbrocca e afferra un’ascia da pompiere corre davanti alla porta della stanza del chitarrista Jerry Miller e del batterista Don Stevenson e cerca di sfondarla.
Skip il gioviale è impazzito. Prima era un amabile ragazzino. Adesso è un aspirante killer psicopatico. Il produttore della band, alla fine, riesce a plac(c)arlo. Meno male che la stanza dei due musicisti era vuota, sennò chissà cosa sarebbe successo.
Poi l’internamento al Bellevue Hospital.
Dove anche Charles Mingus fu rinchiuso. L’acido ha giocato un ruolo in questa faccenda? Sì e no, ma più no che sì; perché sebbene il famoso Orange Sunshine, oggi lo sappiamo, allora in voga, non fosse esattamente acido di prima qualità, è anche vero che Skip era uno schizofrenico latente, e che probabilmente se non ci fosse stato questo episodio a far scattare la schizofrenia paranoide ce ne sarebbe stato qualcun altro più in là nel tempo.
Perché un demone s’impossessò di lui e non lo fece più libero fino all’anno della morte?
No, direi che andava e veniva. All’inizio. Per un po’. Poi, con gli anni Settanta, il declino prese una piega irreversibile. Ebbe altre ban, suonò con il suo vecchio gruppo, ma ormai le droghe, l’alcolismo e la malattia mentale gli impedivano di avere una carriera continuativa e produttiva nel music biz.
Ebbe comunque quattro figli, di cui uno in particolare rimase al suo capezzale in punto di morte. Il resto non è dato sapere. È un segreto che Skip s’è portato nell’Aldilà.
Che cosa prova dopo tanti anni e dopo tanti ascolti quando fa partire Cripple Creek?
Provo fin da subito la sensazione che quella voce cupa mi trascini in fondo a una palude dove ad attendermi c’è una visione, che è un po’ fiaba e un po’ parabola, che musicalmente è parente di tutto il folk rock e il cantautorato dei Sixties eppure non ha nulla a che spartire con loro, perché è davvero molto più ahead of the time di tutti.
His death, it died quite easily/Right there, was gone for good/But he couldn’t see his loved one/Like he thought he should: una strofa della canzone che taglia in diagonale. Traslato: il segno che siamo votati al fallimento?
Questi versi sono una macchina da presa che passa dal fuori al dentro come niente fosse. Mi viene in mente un passaggio di Madame Bovary dove Flaubert inizia descrivendo l’interno della casa della protagonista e poi, attratto dalle voci che provengono dall’esterno della finestra aperta, muove la telecamera della sua narrazione al paesaggio esterno.
Questi versi racchiudono più significati della somma dei significanti che li compongono, pertanto possono essere definiti senza tema di smentita poesia. Poi: più che il fallimento, questi versi sono un’ode all’impotenza e agli istanti fatali che giungono tremendi e soavi come i versi di questa canzone/parabola/poesia.
Perché è abitudine dire che la sua unica prova da solista Oar è un disco difficile da spiegare?
Perché qualunque cosa eluda il canone è e non è un prodotto, discografico nel caso. C’è in giro troppa gente che confonde la buona musica con la musica innovativa e geniale tout court, e questo significa che non hanno i mezzi culturali per “sezionare” un’opera, di qualsiasi natura essa sia.
È diventato col tempo un disco di culto. Però in effetti parliamo di un musicista conosciuto da un numero non certo alto di ammiratori. Come si collimano le due cose?
È come la storiella, narrata da Patti Smith, che diceva che tutti quelli che avevano comprato il primo disco dei Velvet Underground al momento della sua uscita, nel 1967, poi avevano messo su una band fondamentale.
E così è: ogni culto richiama degli adepti, che per quanto esigui costituiscono l’osso duro di quel culto. È così dai tempi di Dioniso ed Eleusi a noi.
Le più recenti immagini di lui ce lo consegnano come un barbone. Basta soffermarsi sul suo volto e scoprire che quelle rughe e quello sguardo contengono ancora una sofferenza infinita.
La sofferenza è fatta per coloro che sanno soffrire, e il tipo dell’uomo-bambino à la Spence sembra quasi fatta apposta per portarsela dietro, come una croce invisibile, eppure visibilissima, a coloro che almeno una volta nella vita hanno vissuto quell’attimo di incendiaria intuizione che la moderna psichiatria chiama malattia mentale.
Corrado Ori Tanzi