Dylan, da Norman Raeben a Retrospectrum
Intervista a Fabio Fantuzzi
Retrospectrum, la mostra di pittura e scultura di Bob Dylan al Maxxi di Roma sta creando un deciso interesse attorno a sé. Con Fantuzzi, già curatore in Italia di Bob Dylan and the Arts, simposio che, da prospettive transdisciplinari, si è occupato del genio Bob Dylan, vediamo di far luce tanto sulla mostra romana quanto sulla figura del suo maestro Raeben…
Retrospectrum, la mostra di pittura e scultura di Bob Dylan al Maxxi di Roma sta creando un deciso interesse attorno a sé, tanto perché si tratta della prima nel nostro Paese dall’artista americano, premio Nobel per la Letteratura nel 2016, quanto ovviamente per il peso del nome dell’artista stesso.
L’incontro, a metà degli anni settanta, con il pittore Norman Raeben fu essenziale per Dylan, non solo per dare corpo alle proprie intuizioni pittoriche quanto per modificare in modo sostanziale la stessa sua tecnica compositiva delle canzoni.
Alla Columbia University di New York, Fabio Fantuzzi, dottore di ricerca in Lingue, Letteratura e Culture Straniere all’Università Tre di Roma, nonché il primo in Italia a presentare una tesi dottorale su Bob Dylan, è al momento impegnato come ricercatore della Ca’ Foscari all’interno del progetto Poyesis che mira a far emergere, tra l’altro, proprio la figura di Raeben e la sua influenza su molteplici artisti della scena newyorchese.
Con Fantuzzi, peraltro già curatore in Italia di Bob Dylan and the Arts, simposio che, da prospettive transdisciplinari, si è occupato del genio Bob Dylan, vediamo di far luce tanto sulla mostra romana quanto sulla figura del suo maestro Raeben.
Come giudica Retrospectrum, la mostra del Bob Dylan pittore e scultore al Maxxi di Roma?

La trovo una mostra singolare e molto dylaniana, tanto nei pregi quanto nelle stranezze. Ha una forma un po’ ibrida, a metà tra una mostra antologica e un viaggio in salsa beat che lascia al visitatore la possibilità di perdersi e di ritrovarsi liberamente all’interno degli svariati cicli di opere esposti che raccontano le diverse sfaccettature di un’America profonda, spesso remota e lontana dai riflettori. O meglio, di quello che ne resta perché nelle sculture e in molti dei quadri predomina la fascinazione per i resti e i rimasugli di quello che gli Stati Uniti hanno lasciato indietro e in parte dimenticato.
Che pittura è quella di Dylan?
È una pittura figurativa dal forte contenuto narrativo che si inserisce nel solco del realismo americano e che guarda indietro fino ai primi del Novecento, rifacendosi soprattutto alla lezione degli artisti dell’Ashcan School of Painting. Come loro, prendendo a prestito una formulazione di Rebecca Zurier, anche Dylan è un mobile observer: un pittore errante attirato principalmente da paesaggi e ambienti urbani tratti dalla vita reale, che cattura i propri motivi in maniera estemporanea, senza patine, filtri o brillantina, cercando di infondere di intensità, naturalezza e, a volte, persino di smaliziata familiarità scene e contesti rispetto ai quali rimane tuttavia fondamentalmente estraneo. Dove si distacca è, invece, nell’uso del colore, spesso applicato a più strati seguendo la tecnica che apprese da Norman Raeben, che in questi dipinti si tinge anche di riferimenti musicali e cinematografici frutto di un immaginario legato all’America della sua giovinezza, al mondo blues e agli itinerari beat.
Come si pone davanti a chi liquida l’interesse per questi dipinti sottolineando che la celebrità dell’autore copre ogni dilettantismo tecnico?
Sicuramente il suo nome attira la curiosità di un pubblico molto ampio e vario, ma sono considerazioni che hanno valenza

esclusivamente dal punto di vista economico, al quale personalmente non sono per nulla interessato. Nel contesto contemporaneo, la tecnica ha un valore relativo: non è un fine, ma un mezzo per esprimere una poetica. In questi cicli traspare una poetica molto chiara, ricca di spunti e inestricabilmente legata al resto della produzione di Dylan, che la perizia tecnica supporta in misura variabile e crescente: le ultime raccolte sono sicuramente molto più pregevoli di quelle iniziali, che del resto, non a caso, sono sottorappresentate.
Dylan le risulta più convincente come pittore o scultore?
È difficile rispondere perché con la scultura compie un’operazione molto diversa legata ai suoi luoghi d’infanzia, che ho compreso grazie un saggio di David Pichaske, incluso in Bob Dylan and the Arts: gli elementi che assembla sono materiali che si trovano comunemente in gran parte dei giardini e dei granai delle aree rurali del Minnesota. La rosa di significati legati all’immagine del cancello, elemento per sua natura paradossale e contrastante perché comunica tanto un senso di sicurezza quanto un’idea di limite e un desiderio di infinito, si sovrappone così anche al problema delle radici, del lavoro e della memoria, sia popolare sia personale. Per certi versi si potrebbe quasi considerarli un’evoluzione del movimento dell’arte povera. Trovo però anche le ultime due collezioni di quadri convincenti e sorprendente il lavoro sulle copertine di diversi magazine.
Si deve parlare di un “altro Dylan” o è possibile individuare tracce o anche solo frammenti della sua arte musicale?
La maschera che Dylan si è costruito nel tempo ha tante facce, tutte diverse ma tra loro familiari perché legate a una medesima poetica artistica. Le sue diverse produzioni condividono immaginari, temi, colori e sonorità. Sebbene al fondo delle sue ricerche ci sia sempre un inesauribile interesse per la cultura popolare, pittura e scultura, così come le altre forme d’arte che ha frequentato, sono però per Dylan degli universi a sé. Le modalità rappresentative e le strategie con cui assembla gli elementi che attinge preferibilmente dall’esterno si differenziano a seconda dei linguaggi che adotta. Pur con le dovute eccezioni, quando frequenta l’universo della canzone sembra più attratto dalle possibilità espressive offerte dal mondo del semiastratto, in pittura è quasi sempre pienamente figurativo, mentre nelle vesti dello scultore, come accennavo in precedenza, si pone a metà tra i due approcci. La scelta di dedicarsi a questi diversi media non è una velleità, ma un’esigenza espressiva: sono diverse facce di una stessa medaglia.
Quando Dylan decise di aprirsi uno spazio creativo extramusicale ed extraletterario attraverso il disegno incontrò Norman Raeben e ne divenne allievo. L’effetto più evidente, nell’espressione artistica per cui lo conosciamo, fu la composizione di Tangled Up In Blue. Quale fu la nuova prospettiva che Dylan fece sua dalle lezioni di Raeben?

L’influenza di Raeben fu cruciale sotto così tanti aspetti che all’interno della mia tesi di dottorato occupa quasi duecento pagine che prima o poi diventeranno un libro. In Tangled Up in Blue Dylan fa in particolare tesoro delle teorie di Raeben sul rapporto tra arte e tempo, inteso ebraicamente come una concrezione di passato e futuro nel flusso continuo del presente, e sulla rappresentazione del soggetto in arte, che viene scomposto e solo rapidamente tratteggiato per poterlo integrare più pienamente nel contesto semiastratto dell’opera. In questo caso, di una canzone che si fa quadro. Al tempo, studiando i libretti su cui Dylan ha scritto le liriche di Blood on the Tracks, trovai ancor più affascinante realizzare che compose l’intero album come fosse un unico ciclo, lavorando a tutti i brani simultaneamente, quasi fossero dei quadri appesi alle pareti di un atelier.
Alla Columbia University di New York lei è impegnato nel progetto Poyesis che, tra l’altro, mira ad accendere una luce proprio su Norman Raeben. Che artista le si sta manifestando?
Quando ho redatto il progetto ero certo di studiare un artista da riscoprire e un insegnante geniale, spiritoso e dalla cultura vastissima. Sapevo anche già che Dylan non era stato che l’ultimo di una lunga schiera di artisti a essere stati influenzati da Raeben nei suoi oltre cinquant’anni di docenza. Una lista che comprende non solo pittori, ma anche esponenti maggiori del teatro yiddish, attori, ballerini e cantanti di Broadway, nonché moltissimi amatori e persone comuni, spesso emigrati di lingua yiddish fuggiti da una terra che purtroppo anche oggi è martoriata dalla guerra. Quello che non mi aspettavo era scoprire un artista d’eccezione, totalmente trascurato dalla critica, in parte perché critico verso le tendenze artistiche in voga al tempo, in parte perché del tutto avverso alle logiche e ai dettami del mercato dell’arte. Spero di riuscire a organizzare presto la prima mostra antologica delle sue opere e realizzarne il catalogo. Tutto questo è possibile grazie alla Commissione Europea che, tramite l’agenda di Horizon Europe, garantisce a noi ricercatori delle opportunità straordinarie, come appunto le borse di mobilità Marie Skłodowska–Curie.
Il prossimo marzo lei sarà, con Alessandro Carrera e Maria Anita Stefanelli, proprio al Maxxi per un convegno su Bob Dylan and the Arts, basato sul volume di cui siete autori e curatori. Prima la mostra, poi questo incontro: significa che anche in Italia sono maturi i tempi per un interesse specifico sulla sua arte visiva, slegato dall’imponente ruolo che questo artista riveste nella cultura contemporanea mondiale?
Questo non lo saprei proprio dire. Mi accontento di attestare che i tempi sono maturi per chiedersi che posto abbia avuto l’arte visiva nella sua carriera e in che modo si leghi all’impatto che Dylan ha avuto sulla cultura contemporanea.
Corrado Ori Tanzi
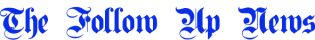
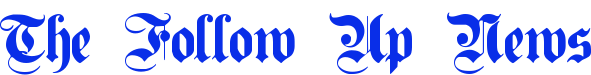

[…] Riprendo sul mio blog l’intervista a Fabio Fantuzzi che ho firmato su The Follow Up News, pubblicata lo scorso 30 genniao e che trovate qui: https://www.followupnewsworld.com/cultura/arte-e-design/2023/dylan-da-norman-raeben-a-retrospectrum. […]